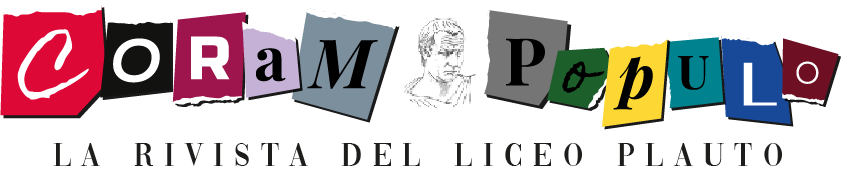di Agnese Cesarii
L’ho visto per la prima volta quarantuno giorni fa. Un incontro casuale, fortuito, ma di quelli che ti cambiano la vita. Di solito quando guardo qualcuno ammiro sul suo viso l’armoniosità dei lineamenti, l’eleganza perfetta del naso, il taglio degli occhi…stavolta no. A colpirmi è stata l’intensità della sofferenza sul volto in penombra, nascosta da una quasi disumana compostezza. Mi ha ricordato una signora anziana vista anni fa, non ricordo neanche dove. Guardava la luna, assorta, grata di quella nuova bellezza che le si presentava intoccata ogni notte. Poi avevo visto le stampelle. Le mancava una gamba, ma nascondeva
il dolore in un innato sogno di vita. E allora, con quella nonnina negli occhi, passavo tutte le mattine davanti alla stanza 219, reparto di psichiatria, anche se sono un chirurgo. Rubavo qualcosa di ignoto dagli occhi di quel ragazzo, mi nutrivo di lui. Non credo se ne accorgesse. Lo vedevo sempre fermo, avviluppato nelle coperte bianche dell’ospedale. Certe volte ci si rotolava dentro come fossero un mare, altre le colpiva ripetutamente, invisibili mostri di farina. E alla fine rideva, instancabile. Io aspettavo con ansia febbrile la fine del mio turno per poter assaporare la felicità della sua vita, così misera ma nella quale
lui sguazzava libero, senza confini. Quella stanza non aveva pareti, era l’estensione della semplicità dolce del suo esistere. Era lì e basta. Lui non si preoccupava del mondo che vorticoso, pieno di camici, gli girava intorno. Forse viveva in un universo fatto di fate, o di cavalieri dalle spade d’oro. Cominciavo a passare molto più tempo davanti al suo vetro appannato. A casa non avevo più nessuno e la sera, quando tornavo esausto da un’altra guerra con la morte, crollavo addormentato ancora vestito, e lo sognavo. Ogni notte.
Poi mi svegliavo urlando, perché lo avevo lasciato lì, a difendersi dalle creature del buio. Da solo. La mattina dopo tornavo in ospedale all’alba, con il cuore in gola per il panico, e quando lo vedevo lì, sdraiato sulle lenzuola appena cambiate, ritornavo finalmente a respirare. Conoscevo a memoria i turni del suo psichiatra, un ometto scialbo, dai radi capelli giallastri, un campo di grano dopo la semina. E quando lo scorgevo allontanarsi a grandi passi con la cartella sottobraccio arrivavo io, furtivo come un ladro, a prendere il mio posto di spettatore disperato di una vita che non era mia. Nemmeno la porta, bianca
come tutto il resto, era più un limite. Mi sedevo ai piedi del suo letto, in religioso silenzio, come davanti a un santo. Bevevo di nascosto i suoi sorrisi al niente, e speravo che qualcuno fosse rivolto a me, come un giovane innamorato. Una volta, stanco di inventarsi battaglie magiche, aveva preso sonno, rannicchiato come un bambino, con la testa che sfiorava la mia gamba. L’avevo accarezzato senza toccarlo, passando la mano a poca distanza dai lunghi capelli neri, e a quel punto mi era sorto irrefrenabile il desiderio di raccontargli una favola. Quelle di mia madre le ricordavo a stento, e non avevo figli a cui tramandarle. Allora avevo deciso di parlargli dei miei sogni. I miei sogni su di lui. In un sussurro, che mi
ero sentito pronunciare con una delicatezza che non mi apparteneva…” c’era una volta un cavaliere dalla spada d’oro. Ma era un cavaliere speciale, e quella spada non la usava nemmeno. Cavalcava giorno e notte il suo destriero nero come l’ebano. Non prendeva mai parte a nessuna battaglia, anche se i sovrani di regni diversi lo reclamavano per la sua risaputa maestria. Il suo unico desiderio era raggiungere il sole.
Voleva godere di quella nascita eterna, e rinascere anche lui. Un giorno riuscì, dopo grandi fatiche, a toccare il gigante con un dito. Si sentì così felice, e ballò mentre il sole gli si inchinava davanti”. Non mi ero mai sentito tanto fragile davanti a qualcuno. Le parole mi uscivano a fiotti, come singhiozzi in un pianto scomposto. Non mi ero neanche accorto che nel frattempo si era svegliato. Stava seduto dritto, con la faccia appoggiata sulle braccia conserte e le ginocchia al petto. Mi osservava con gli occhi sgranati, scurissimi. Ma non ci vedevo paura dentro. Semplicemente mi capiva, e voleva ascoltare. Chissà da quanto tempo non sentiva qualcuno parlare. Viveva in un sogno e mi sentiva raccontargliene uno! E allora avevo continuato a parlare, a donargli nuovo desiderio di vita, cioè di sogno. Il giorno dopo lo avevo colto in un dormiveglia leggero. Allo scricchiolio delle molle del letto cedevoli sotto il mio peso, si era subito alzato. Sembrava fingesse di dormire per ingannare il tempo. Mi faceva piacere che avesse fatto sua quest’abitudine di incontrarci, all’insaputa di tutti. E allora mi ero sistemato, la sacralità di un sacerdote, con il volto verso il suo e gli avevo sorriso per primo, disegnando un cuore con il dito. Si era subito emozionato, e aveva iniziato a dipingere strani cerchi davanti ai miei occhi… stelle, alberi, lune. Poi improvvisamente, si era accasciato sul letto, l’espressione seria ma contratta, nella tensione dell’ascolto.
“C’era una volta un ragazzo molto bello. Aveva lunghi capelli, nerissimi, come gli occhi. Viveva in una stanza con quattro pareti, che sapeva far diventare mille. Il suo migliore amico era un medico e lo andava trovare ogni giorno. Insieme sognavano, anche se il medico non aveva più molta fantasia e doveva chiederla in prestito a quel ragazzo tanto intelligente. Abitavano tutti e due nell’ospedale. Per loro era una casa, perché fuori non c’era nessuno ad aspettarli. Loro due, da soli, erano diventati una piccola famiglia”.
Lui si era messo a battere le mani, ridendo a crepapelle, ed era arrivato persino a poggiare la sua testa sulla mia spalla, per qualche interminabile istante che io avevo accolto con amore paterno.
Sono passati due anni da quest’ultima favola. Sto scrivendo per ricordare. Per non dimenticarmi mai di come ho conosciuto mio figlio. La mattina dell’adozione, mentre lo conducevo per mano alla sua nuova casa, che era finalmente la nostra, cercava di toccare il sole con un dito. Per la prima volta sotto il cielo terso, e non più dal vetro di una finestra. Per la prima volta era libero, anche se, in fondo, lo era sempre stato.